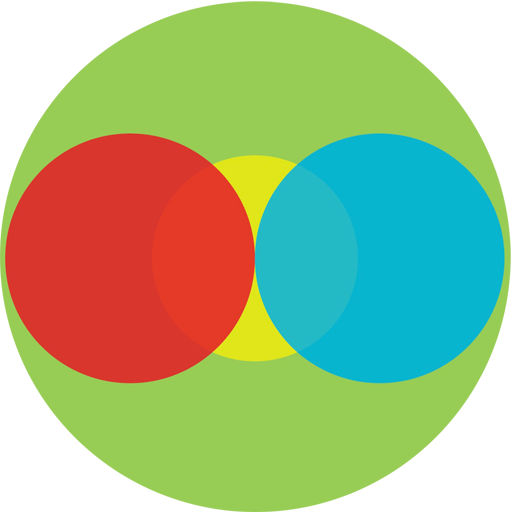“Il nostro compito è quello di compenetrarci così profondamente, dolorosamente e appassionatamente con questa Terra provvisoria e precaria, che la sua essenza rinasca invisibilmente in noi.
Noi siamo le api dell’invisibile.
Noi raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d’oro dell’invisibile”
R. M. Rilke
Qual è la trama invisibile della nostra vita psichica?
Quali voci invisibili parlano attraverso il nostro corpo malato?
Quale sensibilità di ascolto è necessaria per registrare l’intensità di quel suono che viene da un altro mondo?
Ogni giorno che passa, nell’espressione del mio lavoro, sento sempre più frequente l’urgenza di ampliare lo sguardo verso quei luoghi che non sono più e che ancora, tuttavia, persistono nel loro accadere. Più mi addentro nel fare analisi, più avverto una netta sensazione di liminarità e dissolvenza tra ciò che percepisco nel corpo del linguaggio e ciò che avverto nell’intensità del suono. Ho sempre più l’impressione che la vita si svolga negli interstizi, nelle pieghe infinite del visibile. Non siamo mai davvero in fondo là dove cerchiamo. La vita autentica si rivela più intimamente in virtù di quel senso di ulteriorità e trascendenza che traduce la mera oggettività del vivere in presagio d’altrove, in complessità impalpabili.
Ogni giorno ascolto corpi che raccontano densità, tormenti, lamenti, grida, mortificazioni, vendette, violenze, godimenti, fughe, agiti: peregrinazioni visibili di presenze invisibili. Ogni giorno quel linguaggio trova parole nuove per configurare scenari che emergono da un unico fondale paludoso e smisurato. Il luogo dell’analisi, in questo senso, è il luogo della perdita. La nostra storia di corpi dolenti si inscrive in un prolungato dolore di perdita: d’amore, di bellezza, di meraviglia. “La conoscenza”, diceva Pasolini, “è nostalgia”. Ma quale nostalgia descrive la nostra psiche? Forse quel “parlar materno” di cui tutti un giorno abbiamo fatto esperienza il cui ritorno è inaccessibile se non per traiettorie invisibili che rivelano e al tempo stesso nascondono la sorgente. La “nostalgia”, scrive Jankelevitch, ha per oggetto la miseria dell’irreversibile”. Non si può più ritornare all’origine del desiderio se non in virtù della mancanza che il medesimo genera. Il passato ritorna non come realtà ma come struggente passione che, se liberata dalla necessità (di coazione, godimento, affrancamento, negazione), può aprire davvero le porte al grande alveare d’oro invisibile. Nel mito, Orfeo compie un viaggio agli inferi verso la perdita, ma è solamente il canto a liberarlo dalla dannazione. Orfeo è una figurazione emblematica della nostalgia. Poeta, cantore, sacerdote, psicopompo: Orfeo è innanzitutto un fenomeno auricolare, come ricorda Hilman. È l’orecchio analitico sempre teso a cogliere l’assente nel flusso del linguaggio, la sfumatura, il bisbiglio, il non detto. Orfeo è in fondo il connettore di questo regno segreto dell’origine, colui che canta “ciò che non può essere e non è stato mai”, viva testimonianza della tragicità di questo straniamento dell’anima, sempre in tensione tra visibile e invisibile. In questo senso, siamo tutti Orfeo quando sperimentiamo l’abbandono e la perdita. Il canto, allora, diviene l’unica possibile espressione sensibile di quell’anelito nostalgico dove l’umano va incontro la divino.
“…Il tuo non esserci
è già caldo di te, ed è più vero,
più del tuo mancarmi. La nostalgia
spesso non distingue. Perché
cercare allora se il tuo influsso
già sento su di me lieve
come un raggio di luna alla finestra.”
R.M. Rilke